PREWAR FOLK
[F] “Prewar Folk: the Old, Weird America 1900-1940”: Dalle prime incisioni su disco negli anni ’10 a Woody Guthrie e Pete Seeger, la storia dell’America dimenticata dei primi decenni del Novecento, quella del folk in bianco e nero [country blues, hillbillly] che pose le basi della musica popular di tutto il secolo. Una vicenda dimenticata e rimossa che vede protagonisti poveri diseredati ed eccentriche dive, ingenui contadini e scaltri professionisti, vagabondi disperati e avventurieri senza scrupoli, peccatori e santi, clown da quattro soldi ed entertainers raffinati: gli autentici geni di una musica che inventò il rock decenni prima che lui nascesse.
"I Libri di Harry #7" [2007] • 208 pagine
Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961) è direttore ed editore della rivista Blow Up, che ha creato nel 1995. Ha collaborato occasionalmente con Dynamo (1996) e Il Mucchio Selvaggio (1996-1997). Nel 1999 ha pubblicato, con Eddy Cilìa, “Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio” (Giunti), guida alle musiche di confine nate e sviluppatesi nel decennio.
Nel 2003 ha curato il volume “Rock e altre contaminazioni” (Tuttle Edizioni), scelta dei 600 album più importanti dal 1887 al 2002. Nel 2004 è stato tra i relatori del convegno internazionale “Nuovo e Utile”, i cui atti sono stati pubblicati in “La creatività a più voci”, a cura di Annamaria Testa (Laterza, 2005).
[FE] “Prewar Folk: the Old, Weird America 1900-1940”: Starting with the first cuts at the beginning of the XXth century to 1940, the history of the forgotten, black & white rural folk America [country blues, hillbillly]. A history of poor people and eccentric divas, hard workers and smart professionals, desperate hobos and unscrupulous adventurers, sinners and saints, clowns and entertainers: the real geniuses of a music that invented rock’n’n’roll many decades before it was born.
"I Libri di Harry #7" [2007] • 208 pages
Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961), Blow Up’s editor and publisher, also contributed to music magazines Dynamo and Il Mucchio Selvaggio between 1996 and 1997. In 1999, he published the book “Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio” (“Post Rock and Beyond: An Introduction to New Millennium Music”, with Eddy Cilìa), a guide to music born during the nineties. In 2003 he edited the book “Rock e altre contaminazioni” (“Rock and other contaminations”), a volume about the 600 most important albums from 1887 to 2002. In 2004 he participated in the international congress “Nuovo e Utile”, and his lectures were published in “La creatività a più voci”, edited by Annamaria Testa (Laterza, 2005).
[F] Di seguito l’indice e un estratto dal primo capitolo del libro:
INDICE
Un’introduzione
1. The New World
2. The New Word
3. Classic Blues
4. American Primitive: Sinners and Saints
5. Black Folk & (Country) Blues
6. Delta Blues
7. Da Memphis a Chicago
8. Texas Blues
9. Piedmont Blues
10. Street Preachers e Gospel Songs
11. Hillbilly & Country
12. Il superamento dell’hillbilly
13. Urban Folk
Una conclusione
Discografia
Bibliografia
Indice dei nomi
A tutti i neri
Di qualunque colore siano
Dovunque si trovino
1. The New World
…Innanzi tutto qualche indicazione di carattere generale e introduttivo. Prima che voce e suono fossero catturati e registrati su supporto la musica veniva commercializzata in forma di spartiti che i musicisti esecutori leggevano e riproducevano. Le prime trasformazioni e riduzioni dei suoni a ‘materia’ fissabile su supporto e poi destinabile al mercato avvennero a partire dalla fine degli anni ’80 dell’800 con i cilindri, piccoli barattoli metallici con una superficie di cera sulla quale si potevano incidere voci e musiche. La riproduzione avveniva in maniera esattamente inversa, e cioè collocando i cilindri registrati all’interno di uno strumento appositamente costruito (il fonografo, inventato da Thomas A. Edison) dove venivano fatti ruotare meccanicamente a circa 160 giri al minuto in modo da permettere alla puntina che li leggeva di trasmettere i suoni a una tromba acustica che li amplificava: “canned music”, “musica in scatola”, la definì con sufficienza e un velo di disprezzo il famoso bandleader e compositore John Philip Sousa. I cilindri potevano immagazzinare un paio di minuti di suono e lavorare una decina di volte prima di perdere le caratteristiche acustiche ma avevano il vantaggio di poter essere nuovamente registrati.
Fino all’inizio degli anni ’10 del ‘900 spartiti e cilindri furono le maniere più diffuse per commercializzare la musica, poi vennero affiancati dai dischi di gommalacca, le cui prime produzioni risalivano agli anni ’90 dell’800 ma che vennero introdotti in massa nel mercato solo nel 1908 dalla Columbia Phonograph Company. Si trattava di piatti pesanti e fragili che funzionavano in maniera simile ai cilindri ma non avevano possibilità di esser riregistrati perché la gommalacca era essiccata e rigida: venivano posti su un grammofono (l’evoluzione del fonografo) e, fatti ruotare a velocità variabili da 74 a 82 giri al minuto, inviavano il suono alla tromba acustica per mezzo di una puntina metallica che veniva appoggiata sopra di essi lavorando per inerzia. I primi dischi realizzati negli anni ’90 avevano un diametro di 7 pollici ma gli standard più diffusi divennero, col nuovo secolo, i 10 e i 12 pollici, i primi utilizzati principalmente per la musica popular e i secondi per la classica e l’operistica. La standardizzazione delle rotazioni a 78 giri al minuto, da cui il nome con cui oggi sono conosciuti (all’epoca per tutti erano semplicemente discs o records), arrivò nel 1925 con l’introduzione della sincronizzazione elettrica.
I primi anni del ‘900 videro quindi le compagnie fonografiche e discografiche di tutto il mondo (negli USA la partita si giocò tra Columbia ed Edison Records) in fermento per affermare prodotti di ogni tipo cercando affannosamente di migliorarne le caratteristiche e la capacità di contenere sempre più suono. Prototipi - non sempre posti in commercio - di cilindri e dischi in gomma, plastica, celluloide, resine diverse e cera sempre più irrobustita si susseguirono fino a che, a partire dagli anni ’10, non ebbero il sopravvento i dischi di gommalacca, che avevano una qualità di registrazione e di riproduzione meno buona dei cilindri e che inizialmente costavano il doppio (un dollaro contro cinquanta centesimi; per fare un confronto, lo stipendio annuo di un operaio si aggirava sui quattrocento dollari) ma presentavano diversi grossi vantaggi: erano più pratici da trasportare e più facili da riporre nei negozi perché occupavano solo spazio utile (a differenza dei cilindri), erano incisi sui due lati e quindi contenevano il doppio di musica e il loro prezzo divenne rapidamente concorrenziale su quello di tutti gli altri supporti. Furono queste caratteristiche, opportunamente aggiustate da una serie di accordi tra le compagnie discografiche (la politica dei prezzi, la spartizione dei mercati), a facilitare la diffusione dei dischi, che crebbe fino a sostituire definitivamente spartiti e cilindri segnando di fatto la nascita dell’epoca della musica registrata e del consumo di massa.
Le prime incisioni su vinile, destinate nel tempo a sostituire quelle di gommalacca, vennero prodotte dalla RCA Victor nel 1930; la resistenza e l’elasticità del nuovo materiale consentivano di produrre dischi dai solchi più sottili e ravvicinati e con rotazioni rallentate fino a 33 e 1/3 giri al minuto, permettendo quindi la fissazione di una quantità molto maggiore di musica e con una qualità acustica nettamente migliore perché il rumore di superficie del vinile era molto meno vistoso di quello della gommalacca. Nell’immediato però il vinile si rivelò un fallimento: la grande depressione economica che afflisse gli USA nella prima metà degli anni ’30 in seguito al crollo di Wall Street rese estremamente difficoltosa la penetrazione del nuovo supporto e la vendita di grammofoni adatti al suo uso. Alla fine degli anni ’30 iniziarono a far capolino i primi Extended Play con due o tre canzoni per lato (per esempio le “Dustbowl Ballads” di Woody Guthrie) ma fino alla fine della seconda guerra mondiale la produzione dei vinili restò limitata ai dischi promozionali per le radio e i locali da ballo. Fu solo nel 1948 che la Columbia lanciò definitivamente sul mercato il Long Play in vinile, registrato a 33 e 1/3 giri e capace di contenere ventitré minuti di musica per ciascun lato. L’anno seguente la RCA Victor produsse il primo 7” a 45 giri, che ebbe un immediato successo e che nel giro di pochissimi anni permise al vinile di sostituire definitivamente la gommalacca (che restò comunque nel mercato fino alla metà degli anni ‘50) aprendo la strada all’ennesima rivoluzione tecnica e artistica.
Dagli anni ‘10 al termine dei ’40 quindi il formato di stampa dominante in tutte le musiche popular fu quello del 10” di gommalacca che girava a 78 giri (circa) e conteneva una canzone per lato, ovviamente monofonica (la stereofonia arrivò nel 1958). Di conseguenza tutti i musicisti di cui parleremo in questo libro erano autori di semplici singoli; i LP e CD a loro attribuiti sono raccolte compilate a partire dagli anni ’50: fino ad allora difatti non esisteva neppure il concetto di ‘album’.
Il primo aspetto culturale da sottolineare in questa serie di rivoluzioni copernicane subite da quella che chiamiamo ‘musica pop’ nel corso del ‘900 è che essa nacque sulla base di evenienze tecniche ancor prima che da strategie commerciali o da esigenze artistiche. I musicisti affrontarono la novità rappresentata dai mezzi della musica registrata e dalle loro successive evoluzioni in maniera naturale, seguendone le forzature e adeguandosi alle distorsioni a cui essi costringevano. Come quando, nel 1928, arrivò il microfono a condensazione, che permise anche a chi aveva una voce non esattamente straordinaria (inevitabilmente richiesta, com’è ovvio, nelle registrazioni precedenti e ancor più nell’epoca pre-registrazione) di farsi sentire forte e chiaro. Questo permise anche a cantanti non particolarmente potenti ma magari più sottilmente espressivi di farsi largo e di elaborare nuove maniere non solo di intendere l’interpretazione di una canzone ma anche e soprattutto di reinterpretarla con arrangiamenti completamente nuovi e non più legati alla staticità d’accompagnamento del ‘bel canto’. Un discorso che sarebbe ripetibile con decine di altri esempi (uno per tutti quello della stereofonia): ciò che abbiamo avvertito come sviluppo artistico e/o distinzione e caratterizzazione estetica è quasi sempre dipeso da innovazioni tecnologiche e non da esigenze culturali.
La più significativa di tutte le svolte tecnologiche di cui la musica è stata protagonista e vittima fu però, come è ovvio, il concetto stesso di registrazione. In un 10” a 78 giri difatti non potevano esser stipati più di tre minuti di musica per lato (solo i 12” utilizzati per la classica arrivavano a cinque minuti) ed è facile comprendere come l’adattamento delle composizioni a quella lunghezza standard sia stata la più rilevante tra le innumerevoli manipolazioni indotte dal mercato sulla forma, e quindi sulla sostanza, musicale. È da questo semplice fatto tecnico che nacque la cognizione - avvertita ancora oggi - che la canzone popular debba avere, quasi inevitabilmente, una durata standard di tre minuti. Prima che venissero registrate e riprodotte tecnicamente, le canzoni avevano difatti lunghezze molto variabili: quelle utilizzate nei locali da ballo erano ben più lunghe di tre minuti e così quelle delle tradizioni rurali, che spesso ereditavano l’epicità (e la logorrea) delle antiche narrazioni folkloriche. Per fare un solo esempio, negli anni ’60 il bluesman Son House ricordava che le canzoni che ascoltava da bambino superavano tranquillamente i dieci minuti arrivando di frequente a toccare i venti (soprattutto nelle esecuzioni dal vivo). Questo significa che quando si trovarono a fare i conti con la possibilità di registrare la propria musica, i musicisti operarono un nettissimo scarto col passato e con la realtà adattando, tagliando o diluendo i ‘fronzoli’ e iniziando a badare all’essenza più immediatamente comunicativa come melodia, ritornello, accordi e scale facilmente memorizzabili.
La nascita del Long Play di vinile, che rese possibile la registrazione di tracce di lunghezze del tutto anomale e inedite rispetto alla prima metà del secolo (nonché l’ascolto di più canzoni in sequenza), spinse ulteriormente in avanti il discorso facendolo per certi versi tornare indietro come un gambero. Ciò che questo provocò esula dal nostro interesse ma è facile immaginare che, per esempio, se è vero che tutto quello che accadde al rock negli anni ‘60 (l’‘allargamento della coscienza’ musicale e non, la psichedelia, le suite, il progressive ecc. ecc.) doveva parecchio a contingenze socio-culturali come le proteste studentesche o la diffusione delle droghe, è ancor più vero che senza l’innovazione tecnologica portata dal LP tutte quelle contingenze sarebbero state nulla, almeno dal punto di vista musicale. È lecito chiedersi, quindi, quanta musica ‘prewar-psichedelica’ o ‘prewar-progressiva’ - indotta dagli stessi e persino maggiori usi e abusi che si registravano negli anni ’20 e ancor prima - ci siamo persi perché non è stata mai registrata…
È ovvio che l’assunto del non detto (perché ‘non rilevato’) sarebbe valido, oltre che per tutte le forme artistiche, anche per le epoche pre-registrazione: di ogni periodo storico sappiamo solo ciò che ci è stato tramandato, tutto il resto è ipotesi e supposizione. Ma a differenza di tutte le altre forme artistiche nate in epoche classiche la musica, con l’epoca della registrazione e del consumo di massa, divenne qualcosa di completamente diverso da prima. Divenne un’altra forma d’arte: un ‘media artistico’ in cui la mistificazione dei contenuti e la manipolazione della forma (ivi compreso l’utilizzo dello studio di registrazione come strumento) erano parte essenziale e creativa della sua natura più intima e non più stravolgimenti della stessa, come sarebbero stati vissuti nelle epoche precedenti, quando le sovrastrutture definivano (anche) le strutture.
La chiave di lettura delle musiche prewar (folk e non solo - diciamo pure di tutto il pop) passa esattamente da qui perché è dalla mancata comprensione dell’aver a che fare con un nuovo ‘media artistico’ - che come tale necessita di nuovi mezzi di interpretazione, lettura e indagine - che si sono generate le infinite distorsioni di cui il pop è stato oggetto nel corso del ‘900. In due parole, le puntigliose distinzioni tra popular music seria e autentica e popular music commerciale e relativi cascami critici che tanto inchiostro hanno fatto versare e tante discussioni hanno generato (e - ahinoi - continuano a generare) laddove ad essa vengono applicati criteri di lettura che non le appartengono (un po’ come discutere di pittura nell’analizzare una fotografia o pensare al cinema come se fosse teatro). Peraltro, fu proprio nel periodo della sua incubazione e del suo sviluppo che il mercato musicale dispiegò meglio la sua vitalistica, inarrestabile, formidabile capacità ‘dissimulatoria’: ecco perché i primi decenni del secolo scorso sono e resteranno i più significativi ed esemplari di tutta l’epoca della musica registrata.
Un rapido cenno riguardo la nascita del copyright sulle canzoni e la popolarità raggiunta dai musicisti in termini di vendite di dischi. Il copyright, croce e delizia di tante futili discussioni dei nostri giorni, nacque ufficialmente nel 1914 con l’ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers, la cugina della nostra SIAE. Furono cinque compositori, un librettista e tre rappresentati degli editori (i publishers) a creare l’associazione al fine di tutelare e regolamentare la diffusione pubblica della musica. Il mercato era infatti maturo perché anche chi scriveva le canzoni partecipasse al banchetto delle sue stesse creazioni, visto che fino ad allora non ne aveva ricavato quasi nulla e che gli unici a guadagnarci sopra erano le etichette che le pubblicavano e i locali (ristoranti, teatri, vaudeville) che le utilizzavano per attirare clienti e pubblico; si trattò insomma di un’istituzione molto simile a un sindacato che difendeva gli interessi del lavoro intellettuale come fosse un qualunque altro tipo di lavoro. Negli anni ’40, come vedremo tra breve, nacque anche una seconda associazione per la tutela degli interessi degli autori e degli editori, la BMI.
Per quanto riguarda la diffusione, nel 1909 le copie vendute di spartiti, cilindri e dischi furono complessivamente quasi 30 milioni e negli anni seguenti il trend aumentò continuamente fino a toccare i 100 milioni del 1919 e i 200 milioni del 1929; le canzoni più popolari arrivavano a vendere, a metà anni ’20, anche un milione e mezzo di copie. Nessuno di quanti saranno trattati in questo libro fu comunque una star nazionale, tutti restarono sempre limitati ai circuiti regionali; le uniche eccezioni furono Bessie Smith (12 presenze in classifica e un numero 1) e Jimmie Rodgers (8 presenze in classifica ma mai in vetta). Il colosso delle vendite della prima metà del secolo fu Bing Crosby con 294 presenze in classifica e 36 numeri 1; dietro di lui una marea di nomi tra i quali spiccano Paul Whiteman, Guy Lombardo e Billy Murray, ciascuno con oltre centocinquanta presenze e decine di numeri 1 (si noti però che di essi oggi non restano che pochissime tracce registrate, e questo deve pur significare qualcosa). Anche musicisti come Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, che sono giustamente considerati punti fermi dell’evoluzione del jazz e del pop, non furono mai celebrità nazionali se non settorialmente (i loro numeri 1 in classifica furono rispettivamente 3, 1, 1, 3 e 1), avevano ben pochi passaggi nelle radio nazionali, facevano pochi concerti nei luoghi che contavano e raramente apparivano nelle colonne sonore dei film. Questo per chiarire che tutto ciò di cui parleremo è definibile, con i parametri odierni, come perfettamente underground: le storie che tracceremo sono quelle degli antenati della musica alternative. Le distanze che separavano il mercato di massa - vale a dire quello popular sul serio - da quello underground erano incolmabili, un po’ come accade ancora oggi: lo spazio di quanti consideriamo giganti artistici, all’interno della globalità del business discografico, è sempre stato molto marginale.
I ‘generi’ musicali di cui ci occuperemo saranno riconducibili sostanzialmente al country blues e all’hillbilly-country, o meglio alle musiche identificate con questi nomi perché tipicizzate come proprie delle culture popolari nere e bianche; vedremo però che si trattava di distinzioni largamente opinabili poiché in ognuna di esse si nascondevano i semi dell’altra fino al punto di renderne indistinguibile l’origine etnica. La musica era acustica e gli strumenti utilizzati erano la chitarra, il banjo, il violino, i jug (recipienti di varia forma e natura da utilizzare soffiandoci dentro), l’armonica e la voce; l’elettrificazione arrivò alla metà degli anni ’30 ma impiegò oltre un decennio prima di affermarsi definitivamente. Le band non avevano sezioni ritmiche come le intendiamo oggi: l’utilizzo del basso e della batteria, mutuati dal jazz (e utilizzati, anche se molto parzialmente, solo nel classic blues, che fu un fenomeno limitrofo al country blues), divenne rilevante nel blues urbano e progressivamente elettrificato che si sviluppò a partire dagli anni ’30. A tenere il ritmo erano la chitarra o gli altri strumenti, spesso utilizzati in forma impropriamente percussiva.
Dimenticate quindi il blues e il country per come li avete conosciuti (e amati, e disprezzati) nella seconda metà del ‘900 e preparatevi ad ascoltarli in un formato quasi indistinguibile: fu difatti il sistema mercantile a indirizzare su esatti binari e coordinate suoni che vivevano proprio nella mancanza di binari e coordinate. Sin dalle loro prime stampe difatti tutte le musiche popolari iniziarono a esser falsate rispetto alla maniera in cui le si potevano ascoltare nelle epoche pre-registrazione, e non solo dal punto di vista strettamente tecnico (come già accenato). Fu l’introduzione del marketing dei generi e dei settori che, mutandone profondamente la natura, le destinò al consumo per fasce razziali ed economiche: fu così che nacquero i race records di blues (e jazz) e la hillbilly music, rispettivamente i dischi incisi da neri e destinati a un pubblico di neri e la musica dei contadini bianchi degli Appalachi, similmente rivolta a un consumo parallelo.
L’atteggiamento dell’industria discografica nel distinguere, catalogare e differenziare le canzoni per fasce etniche non era però dovuto a razzismo o a improbabili velleità puriste; questo è solo l’aspetto più insistentemente sottolineato dalle frange più pateticamente politicizzate della critica, che si crogiola(va)no nella perpetua lamentazione dei condizionamenti razziali e razzisti del mercato e della cultura americani. È indubbio, ovviamente, che i sentimenti diffusi della società bianca fossero tali ma nel concreto del discorso mercantile essi restarono sempre marginali o comunque significativi solo di riflesso. La realtà dell’industria era molto più semplice: differenziare il mercato il più possibile. La cultura bianca americana, si sa, è innanzi tutto pragmatica, e particolarmente se si tratta di business. Sin dai suoi esordi l’industria discografica (in realtà qualunque tipo di industria) tese alla moltiplicazione dei settori perché la differenziazione stabilisce, sostiene e rafforza l’autoriconoscibilità dei consumatori e quindi il loro attaccamento al prodotto, soprattutto in un ambito dalla forte partecipazione emotiva come era (è) quello media-artistico della musica pop. Più il mercato si allarga (o, se si preferisce, al fine di allargare il mercato), più diventa necessario creare nicchie particolari, originali, uniche all’interno delle quali ogni singolo ascoltatore riesce a riconoscersi per trasformarsi in consumatore consenziente e attivo. La storia della musica del ‘900 - non solo popular - non è altro che un susseguirsi di mode e trend esattamente per questo: la creazione di hillbilly records e race records non ne fu che la prova generale e, in questo, anche la più perfetta e a tutt’oggi insuperata delle prove. L’unica a essere completamente eterodiretta, è importante sottolineare, laddove tutte le seguenti, dal r’n’r al beat, dalla psichedelia al prog, dal punk al post rock all’hip hop e quant’altro, nacquero sempre dall’interazione col pubblico di massa e dai cortocircuiti socioculturali che esso esprimeva ed esprime. A dispetto di come potrebbe apparire, inoltre, la divisione commerciale tra hillbilly e race records fu una manna dal cielo per tutti, in particolar modo per le comunità nere. Perché fece la fortuna di moltissimi diseredati senza arte né parte, fu la formula magica che permise la creazione di un radicato e sempre più florido mercato afroamericano altrimenti ben difficile anche da ipotizzare. Il ghetto, in tal senso, pagò (e paga ancora) benissimo…
© Tuttle Edizioni 2008
Prezzo: 7 €
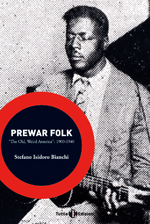
[F] “Prewar Folk: the Old, Weird America 1900-1940”: Dalle prime incisioni su disco negli anni ’10 a Woody Guthrie e Pete Seeger, la storia dell’America dimenticata dei primi decenni del Novecento, quella del folk in bianco e nero [country blues, hillbillly] che pose le basi della musica popular di tutto il secolo. Una vicenda dimenticata e rimossa che vede protagonisti poveri diseredati ed eccentriche dive, ingenui contadini e scaltri professionisti, vagabondi disperati e avventurieri senza scrupoli, peccatori e santi, clown da quattro soldi ed entertainers raffinati: gli autentici geni di una musica che inventò il rock decenni prima che lui nascesse.
"I Libri di Harry #7" [2007] • 208 pagine
Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961) è direttore ed editore della rivista Blow Up, che ha creato nel 1995. Ha collaborato occasionalmente con Dynamo (1996) e Il Mucchio Selvaggio (1996-1997). Nel 1999 ha pubblicato, con Eddy Cilìa, “Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio” (Giunti), guida alle musiche di confine nate e sviluppatesi nel decennio.
Nel 2003 ha curato il volume “Rock e altre contaminazioni” (Tuttle Edizioni), scelta dei 600 album più importanti dal 1887 al 2002. Nel 2004 è stato tra i relatori del convegno internazionale “Nuovo e Utile”, i cui atti sono stati pubblicati in “La creatività a più voci”, a cura di Annamaria Testa (Laterza, 2005).
[FE] “Prewar Folk: the Old, Weird America 1900-1940”: Starting with the first cuts at the beginning of the XXth century to 1940, the history of the forgotten, black & white rural folk America [country blues, hillbillly]. A history of poor people and eccentric divas, hard workers and smart professionals, desperate hobos and unscrupulous adventurers, sinners and saints, clowns and entertainers: the real geniuses of a music that invented rock’n’n’roll many decades before it was born.
"I Libri di Harry #7" [2007] • 208 pages
Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961), Blow Up’s editor and publisher, also contributed to music magazines Dynamo and Il Mucchio Selvaggio between 1996 and 1997. In 1999, he published the book “Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio” (“Post Rock and Beyond: An Introduction to New Millennium Music”, with Eddy Cilìa), a guide to music born during the nineties. In 2003 he edited the book “Rock e altre contaminazioni” (“Rock and other contaminations”), a volume about the 600 most important albums from 1887 to 2002. In 2004 he participated in the international congress “Nuovo e Utile”, and his lectures were published in “La creatività a più voci”, edited by Annamaria Testa (Laterza, 2005).
[F] Di seguito l’indice e un estratto dal primo capitolo del libro:
INDICE
Un’introduzione
1. The New World
2. The New Word
3. Classic Blues
4. American Primitive: Sinners and Saints
5. Black Folk & (Country) Blues
6. Delta Blues
7. Da Memphis a Chicago
8. Texas Blues
9. Piedmont Blues
10. Street Preachers e Gospel Songs
11. Hillbilly & Country
12. Il superamento dell’hillbilly
13. Urban Folk
Una conclusione
Discografia
Bibliografia
Indice dei nomi
A tutti i neri
Di qualunque colore siano
Dovunque si trovino
1. The New World
…Innanzi tutto qualche indicazione di carattere generale e introduttivo. Prima che voce e suono fossero catturati e registrati su supporto la musica veniva commercializzata in forma di spartiti che i musicisti esecutori leggevano e riproducevano. Le prime trasformazioni e riduzioni dei suoni a ‘materia’ fissabile su supporto e poi destinabile al mercato avvennero a partire dalla fine degli anni ’80 dell’800 con i cilindri, piccoli barattoli metallici con una superficie di cera sulla quale si potevano incidere voci e musiche. La riproduzione avveniva in maniera esattamente inversa, e cioè collocando i cilindri registrati all’interno di uno strumento appositamente costruito (il fonografo, inventato da Thomas A. Edison) dove venivano fatti ruotare meccanicamente a circa 160 giri al minuto in modo da permettere alla puntina che li leggeva di trasmettere i suoni a una tromba acustica che li amplificava: “canned music”, “musica in scatola”, la definì con sufficienza e un velo di disprezzo il famoso bandleader e compositore John Philip Sousa. I cilindri potevano immagazzinare un paio di minuti di suono e lavorare una decina di volte prima di perdere le caratteristiche acustiche ma avevano il vantaggio di poter essere nuovamente registrati.
Fino all’inizio degli anni ’10 del ‘900 spartiti e cilindri furono le maniere più diffuse per commercializzare la musica, poi vennero affiancati dai dischi di gommalacca, le cui prime produzioni risalivano agli anni ’90 dell’800 ma che vennero introdotti in massa nel mercato solo nel 1908 dalla Columbia Phonograph Company. Si trattava di piatti pesanti e fragili che funzionavano in maniera simile ai cilindri ma non avevano possibilità di esser riregistrati perché la gommalacca era essiccata e rigida: venivano posti su un grammofono (l’evoluzione del fonografo) e, fatti ruotare a velocità variabili da 74 a 82 giri al minuto, inviavano il suono alla tromba acustica per mezzo di una puntina metallica che veniva appoggiata sopra di essi lavorando per inerzia. I primi dischi realizzati negli anni ’90 avevano un diametro di 7 pollici ma gli standard più diffusi divennero, col nuovo secolo, i 10 e i 12 pollici, i primi utilizzati principalmente per la musica popular e i secondi per la classica e l’operistica. La standardizzazione delle rotazioni a 78 giri al minuto, da cui il nome con cui oggi sono conosciuti (all’epoca per tutti erano semplicemente discs o records), arrivò nel 1925 con l’introduzione della sincronizzazione elettrica.
I primi anni del ‘900 videro quindi le compagnie fonografiche e discografiche di tutto il mondo (negli USA la partita si giocò tra Columbia ed Edison Records) in fermento per affermare prodotti di ogni tipo cercando affannosamente di migliorarne le caratteristiche e la capacità di contenere sempre più suono. Prototipi - non sempre posti in commercio - di cilindri e dischi in gomma, plastica, celluloide, resine diverse e cera sempre più irrobustita si susseguirono fino a che, a partire dagli anni ’10, non ebbero il sopravvento i dischi di gommalacca, che avevano una qualità di registrazione e di riproduzione meno buona dei cilindri e che inizialmente costavano il doppio (un dollaro contro cinquanta centesimi; per fare un confronto, lo stipendio annuo di un operaio si aggirava sui quattrocento dollari) ma presentavano diversi grossi vantaggi: erano più pratici da trasportare e più facili da riporre nei negozi perché occupavano solo spazio utile (a differenza dei cilindri), erano incisi sui due lati e quindi contenevano il doppio di musica e il loro prezzo divenne rapidamente concorrenziale su quello di tutti gli altri supporti. Furono queste caratteristiche, opportunamente aggiustate da una serie di accordi tra le compagnie discografiche (la politica dei prezzi, la spartizione dei mercati), a facilitare la diffusione dei dischi, che crebbe fino a sostituire definitivamente spartiti e cilindri segnando di fatto la nascita dell’epoca della musica registrata e del consumo di massa.
Le prime incisioni su vinile, destinate nel tempo a sostituire quelle di gommalacca, vennero prodotte dalla RCA Victor nel 1930; la resistenza e l’elasticità del nuovo materiale consentivano di produrre dischi dai solchi più sottili e ravvicinati e con rotazioni rallentate fino a 33 e 1/3 giri al minuto, permettendo quindi la fissazione di una quantità molto maggiore di musica e con una qualità acustica nettamente migliore perché il rumore di superficie del vinile era molto meno vistoso di quello della gommalacca. Nell’immediato però il vinile si rivelò un fallimento: la grande depressione economica che afflisse gli USA nella prima metà degli anni ’30 in seguito al crollo di Wall Street rese estremamente difficoltosa la penetrazione del nuovo supporto e la vendita di grammofoni adatti al suo uso. Alla fine degli anni ’30 iniziarono a far capolino i primi Extended Play con due o tre canzoni per lato (per esempio le “Dustbowl Ballads” di Woody Guthrie) ma fino alla fine della seconda guerra mondiale la produzione dei vinili restò limitata ai dischi promozionali per le radio e i locali da ballo. Fu solo nel 1948 che la Columbia lanciò definitivamente sul mercato il Long Play in vinile, registrato a 33 e 1/3 giri e capace di contenere ventitré minuti di musica per ciascun lato. L’anno seguente la RCA Victor produsse il primo 7” a 45 giri, che ebbe un immediato successo e che nel giro di pochissimi anni permise al vinile di sostituire definitivamente la gommalacca (che restò comunque nel mercato fino alla metà degli anni ‘50) aprendo la strada all’ennesima rivoluzione tecnica e artistica.
Dagli anni ‘10 al termine dei ’40 quindi il formato di stampa dominante in tutte le musiche popular fu quello del 10” di gommalacca che girava a 78 giri (circa) e conteneva una canzone per lato, ovviamente monofonica (la stereofonia arrivò nel 1958). Di conseguenza tutti i musicisti di cui parleremo in questo libro erano autori di semplici singoli; i LP e CD a loro attribuiti sono raccolte compilate a partire dagli anni ’50: fino ad allora difatti non esisteva neppure il concetto di ‘album’.
Il primo aspetto culturale da sottolineare in questa serie di rivoluzioni copernicane subite da quella che chiamiamo ‘musica pop’ nel corso del ‘900 è che essa nacque sulla base di evenienze tecniche ancor prima che da strategie commerciali o da esigenze artistiche. I musicisti affrontarono la novità rappresentata dai mezzi della musica registrata e dalle loro successive evoluzioni in maniera naturale, seguendone le forzature e adeguandosi alle distorsioni a cui essi costringevano. Come quando, nel 1928, arrivò il microfono a condensazione, che permise anche a chi aveva una voce non esattamente straordinaria (inevitabilmente richiesta, com’è ovvio, nelle registrazioni precedenti e ancor più nell’epoca pre-registrazione) di farsi sentire forte e chiaro. Questo permise anche a cantanti non particolarmente potenti ma magari più sottilmente espressivi di farsi largo e di elaborare nuove maniere non solo di intendere l’interpretazione di una canzone ma anche e soprattutto di reinterpretarla con arrangiamenti completamente nuovi e non più legati alla staticità d’accompagnamento del ‘bel canto’. Un discorso che sarebbe ripetibile con decine di altri esempi (uno per tutti quello della stereofonia): ciò che abbiamo avvertito come sviluppo artistico e/o distinzione e caratterizzazione estetica è quasi sempre dipeso da innovazioni tecnologiche e non da esigenze culturali.
La più significativa di tutte le svolte tecnologiche di cui la musica è stata protagonista e vittima fu però, come è ovvio, il concetto stesso di registrazione. In un 10” a 78 giri difatti non potevano esser stipati più di tre minuti di musica per lato (solo i 12” utilizzati per la classica arrivavano a cinque minuti) ed è facile comprendere come l’adattamento delle composizioni a quella lunghezza standard sia stata la più rilevante tra le innumerevoli manipolazioni indotte dal mercato sulla forma, e quindi sulla sostanza, musicale. È da questo semplice fatto tecnico che nacque la cognizione - avvertita ancora oggi - che la canzone popular debba avere, quasi inevitabilmente, una durata standard di tre minuti. Prima che venissero registrate e riprodotte tecnicamente, le canzoni avevano difatti lunghezze molto variabili: quelle utilizzate nei locali da ballo erano ben più lunghe di tre minuti e così quelle delle tradizioni rurali, che spesso ereditavano l’epicità (e la logorrea) delle antiche narrazioni folkloriche. Per fare un solo esempio, negli anni ’60 il bluesman Son House ricordava che le canzoni che ascoltava da bambino superavano tranquillamente i dieci minuti arrivando di frequente a toccare i venti (soprattutto nelle esecuzioni dal vivo). Questo significa che quando si trovarono a fare i conti con la possibilità di registrare la propria musica, i musicisti operarono un nettissimo scarto col passato e con la realtà adattando, tagliando o diluendo i ‘fronzoli’ e iniziando a badare all’essenza più immediatamente comunicativa come melodia, ritornello, accordi e scale facilmente memorizzabili.
La nascita del Long Play di vinile, che rese possibile la registrazione di tracce di lunghezze del tutto anomale e inedite rispetto alla prima metà del secolo (nonché l’ascolto di più canzoni in sequenza), spinse ulteriormente in avanti il discorso facendolo per certi versi tornare indietro come un gambero. Ciò che questo provocò esula dal nostro interesse ma è facile immaginare che, per esempio, se è vero che tutto quello che accadde al rock negli anni ‘60 (l’‘allargamento della coscienza’ musicale e non, la psichedelia, le suite, il progressive ecc. ecc.) doveva parecchio a contingenze socio-culturali come le proteste studentesche o la diffusione delle droghe, è ancor più vero che senza l’innovazione tecnologica portata dal LP tutte quelle contingenze sarebbero state nulla, almeno dal punto di vista musicale. È lecito chiedersi, quindi, quanta musica ‘prewar-psichedelica’ o ‘prewar-progressiva’ - indotta dagli stessi e persino maggiori usi e abusi che si registravano negli anni ’20 e ancor prima - ci siamo persi perché non è stata mai registrata…
È ovvio che l’assunto del non detto (perché ‘non rilevato’) sarebbe valido, oltre che per tutte le forme artistiche, anche per le epoche pre-registrazione: di ogni periodo storico sappiamo solo ciò che ci è stato tramandato, tutto il resto è ipotesi e supposizione. Ma a differenza di tutte le altre forme artistiche nate in epoche classiche la musica, con l’epoca della registrazione e del consumo di massa, divenne qualcosa di completamente diverso da prima. Divenne un’altra forma d’arte: un ‘media artistico’ in cui la mistificazione dei contenuti e la manipolazione della forma (ivi compreso l’utilizzo dello studio di registrazione come strumento) erano parte essenziale e creativa della sua natura più intima e non più stravolgimenti della stessa, come sarebbero stati vissuti nelle epoche precedenti, quando le sovrastrutture definivano (anche) le strutture.
La chiave di lettura delle musiche prewar (folk e non solo - diciamo pure di tutto il pop) passa esattamente da qui perché è dalla mancata comprensione dell’aver a che fare con un nuovo ‘media artistico’ - che come tale necessita di nuovi mezzi di interpretazione, lettura e indagine - che si sono generate le infinite distorsioni di cui il pop è stato oggetto nel corso del ‘900. In due parole, le puntigliose distinzioni tra popular music seria e autentica e popular music commerciale e relativi cascami critici che tanto inchiostro hanno fatto versare e tante discussioni hanno generato (e - ahinoi - continuano a generare) laddove ad essa vengono applicati criteri di lettura che non le appartengono (un po’ come discutere di pittura nell’analizzare una fotografia o pensare al cinema come se fosse teatro). Peraltro, fu proprio nel periodo della sua incubazione e del suo sviluppo che il mercato musicale dispiegò meglio la sua vitalistica, inarrestabile, formidabile capacità ‘dissimulatoria’: ecco perché i primi decenni del secolo scorso sono e resteranno i più significativi ed esemplari di tutta l’epoca della musica registrata.
Un rapido cenno riguardo la nascita del copyright sulle canzoni e la popolarità raggiunta dai musicisti in termini di vendite di dischi. Il copyright, croce e delizia di tante futili discussioni dei nostri giorni, nacque ufficialmente nel 1914 con l’ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers, la cugina della nostra SIAE. Furono cinque compositori, un librettista e tre rappresentati degli editori (i publishers) a creare l’associazione al fine di tutelare e regolamentare la diffusione pubblica della musica. Il mercato era infatti maturo perché anche chi scriveva le canzoni partecipasse al banchetto delle sue stesse creazioni, visto che fino ad allora non ne aveva ricavato quasi nulla e che gli unici a guadagnarci sopra erano le etichette che le pubblicavano e i locali (ristoranti, teatri, vaudeville) che le utilizzavano per attirare clienti e pubblico; si trattò insomma di un’istituzione molto simile a un sindacato che difendeva gli interessi del lavoro intellettuale come fosse un qualunque altro tipo di lavoro. Negli anni ’40, come vedremo tra breve, nacque anche una seconda associazione per la tutela degli interessi degli autori e degli editori, la BMI.
Per quanto riguarda la diffusione, nel 1909 le copie vendute di spartiti, cilindri e dischi furono complessivamente quasi 30 milioni e negli anni seguenti il trend aumentò continuamente fino a toccare i 100 milioni del 1919 e i 200 milioni del 1929; le canzoni più popolari arrivavano a vendere, a metà anni ’20, anche un milione e mezzo di copie. Nessuno di quanti saranno trattati in questo libro fu comunque una star nazionale, tutti restarono sempre limitati ai circuiti regionali; le uniche eccezioni furono Bessie Smith (12 presenze in classifica e un numero 1) e Jimmie Rodgers (8 presenze in classifica ma mai in vetta). Il colosso delle vendite della prima metà del secolo fu Bing Crosby con 294 presenze in classifica e 36 numeri 1; dietro di lui una marea di nomi tra i quali spiccano Paul Whiteman, Guy Lombardo e Billy Murray, ciascuno con oltre centocinquanta presenze e decine di numeri 1 (si noti però che di essi oggi non restano che pochissime tracce registrate, e questo deve pur significare qualcosa). Anche musicisti come Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, che sono giustamente considerati punti fermi dell’evoluzione del jazz e del pop, non furono mai celebrità nazionali se non settorialmente (i loro numeri 1 in classifica furono rispettivamente 3, 1, 1, 3 e 1), avevano ben pochi passaggi nelle radio nazionali, facevano pochi concerti nei luoghi che contavano e raramente apparivano nelle colonne sonore dei film. Questo per chiarire che tutto ciò di cui parleremo è definibile, con i parametri odierni, come perfettamente underground: le storie che tracceremo sono quelle degli antenati della musica alternative. Le distanze che separavano il mercato di massa - vale a dire quello popular sul serio - da quello underground erano incolmabili, un po’ come accade ancora oggi: lo spazio di quanti consideriamo giganti artistici, all’interno della globalità del business discografico, è sempre stato molto marginale.
I ‘generi’ musicali di cui ci occuperemo saranno riconducibili sostanzialmente al country blues e all’hillbilly-country, o meglio alle musiche identificate con questi nomi perché tipicizzate come proprie delle culture popolari nere e bianche; vedremo però che si trattava di distinzioni largamente opinabili poiché in ognuna di esse si nascondevano i semi dell’altra fino al punto di renderne indistinguibile l’origine etnica. La musica era acustica e gli strumenti utilizzati erano la chitarra, il banjo, il violino, i jug (recipienti di varia forma e natura da utilizzare soffiandoci dentro), l’armonica e la voce; l’elettrificazione arrivò alla metà degli anni ’30 ma impiegò oltre un decennio prima di affermarsi definitivamente. Le band non avevano sezioni ritmiche come le intendiamo oggi: l’utilizzo del basso e della batteria, mutuati dal jazz (e utilizzati, anche se molto parzialmente, solo nel classic blues, che fu un fenomeno limitrofo al country blues), divenne rilevante nel blues urbano e progressivamente elettrificato che si sviluppò a partire dagli anni ’30. A tenere il ritmo erano la chitarra o gli altri strumenti, spesso utilizzati in forma impropriamente percussiva.
Dimenticate quindi il blues e il country per come li avete conosciuti (e amati, e disprezzati) nella seconda metà del ‘900 e preparatevi ad ascoltarli in un formato quasi indistinguibile: fu difatti il sistema mercantile a indirizzare su esatti binari e coordinate suoni che vivevano proprio nella mancanza di binari e coordinate. Sin dalle loro prime stampe difatti tutte le musiche popolari iniziarono a esser falsate rispetto alla maniera in cui le si potevano ascoltare nelle epoche pre-registrazione, e non solo dal punto di vista strettamente tecnico (come già accenato). Fu l’introduzione del marketing dei generi e dei settori che, mutandone profondamente la natura, le destinò al consumo per fasce razziali ed economiche: fu così che nacquero i race records di blues (e jazz) e la hillbilly music, rispettivamente i dischi incisi da neri e destinati a un pubblico di neri e la musica dei contadini bianchi degli Appalachi, similmente rivolta a un consumo parallelo.
L’atteggiamento dell’industria discografica nel distinguere, catalogare e differenziare le canzoni per fasce etniche non era però dovuto a razzismo o a improbabili velleità puriste; questo è solo l’aspetto più insistentemente sottolineato dalle frange più pateticamente politicizzate della critica, che si crogiola(va)no nella perpetua lamentazione dei condizionamenti razziali e razzisti del mercato e della cultura americani. È indubbio, ovviamente, che i sentimenti diffusi della società bianca fossero tali ma nel concreto del discorso mercantile essi restarono sempre marginali o comunque significativi solo di riflesso. La realtà dell’industria era molto più semplice: differenziare il mercato il più possibile. La cultura bianca americana, si sa, è innanzi tutto pragmatica, e particolarmente se si tratta di business. Sin dai suoi esordi l’industria discografica (in realtà qualunque tipo di industria) tese alla moltiplicazione dei settori perché la differenziazione stabilisce, sostiene e rafforza l’autoriconoscibilità dei consumatori e quindi il loro attaccamento al prodotto, soprattutto in un ambito dalla forte partecipazione emotiva come era (è) quello media-artistico della musica pop. Più il mercato si allarga (o, se si preferisce, al fine di allargare il mercato), più diventa necessario creare nicchie particolari, originali, uniche all’interno delle quali ogni singolo ascoltatore riesce a riconoscersi per trasformarsi in consumatore consenziente e attivo. La storia della musica del ‘900 - non solo popular - non è altro che un susseguirsi di mode e trend esattamente per questo: la creazione di hillbilly records e race records non ne fu che la prova generale e, in questo, anche la più perfetta e a tutt’oggi insuperata delle prove. L’unica a essere completamente eterodiretta, è importante sottolineare, laddove tutte le seguenti, dal r’n’r al beat, dalla psichedelia al prog, dal punk al post rock all’hip hop e quant’altro, nacquero sempre dall’interazione col pubblico di massa e dai cortocircuiti socioculturali che esso esprimeva ed esprime. A dispetto di come potrebbe apparire, inoltre, la divisione commerciale tra hillbilly e race records fu una manna dal cielo per tutti, in particolar modo per le comunità nere. Perché fece la fortuna di moltissimi diseredati senza arte né parte, fu la formula magica che permise la creazione di un radicato e sempre più florido mercato afroamericano altrimenti ben difficile anche da ipotizzare. Il ghetto, in tal senso, pagò (e paga ancora) benissimo…
© Tuttle Edizioni 2008
"I Libri di Harry #7" [2007] • 208 pagine
Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961) è direttore ed editore della rivista Blow Up, che ha creato nel 1995. Ha collaborato occasionalmente con Dynamo (1996) e Il Mucchio Selvaggio (1996-1997). Nel 1999 ha pubblicato, con Eddy Cilìa, “Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio” (Giunti), guida alle musiche di confine nate e sviluppatesi nel decennio.
Nel 2003 ha curato il volume “Rock e altre contaminazioni” (Tuttle Edizioni), scelta dei 600 album più importanti dal 1887 al 2002. Nel 2004 è stato tra i relatori del convegno internazionale “Nuovo e Utile”, i cui atti sono stati pubblicati in “La creatività a più voci”, a cura di Annamaria Testa (Laterza, 2005).
[FE] “Prewar Folk: the Old, Weird America 1900-1940”: Starting with the first cuts at the beginning of the XXth century to 1940, the history of the forgotten, black & white rural folk America [country blues, hillbillly]. A history of poor people and eccentric divas, hard workers and smart professionals, desperate hobos and unscrupulous adventurers, sinners and saints, clowns and entertainers: the real geniuses of a music that invented rock’n’n’roll many decades before it was born.
"I Libri di Harry #7" [2007] • 208 pages
Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961), Blow Up’s editor and publisher, also contributed to music magazines Dynamo and Il Mucchio Selvaggio between 1996 and 1997. In 1999, he published the book “Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio” (“Post Rock and Beyond: An Introduction to New Millennium Music”, with Eddy Cilìa), a guide to music born during the nineties. In 2003 he edited the book “Rock e altre contaminazioni” (“Rock and other contaminations”), a volume about the 600 most important albums from 1887 to 2002. In 2004 he participated in the international congress “Nuovo e Utile”, and his lectures were published in “La creatività a più voci”, edited by Annamaria Testa (Laterza, 2005).
[F] Di seguito l’indice e un estratto dal primo capitolo del libro:
INDICE
Un’introduzione
1. The New World
2. The New Word
3. Classic Blues
4. American Primitive: Sinners and Saints
5. Black Folk & (Country) Blues
6. Delta Blues
7. Da Memphis a Chicago
8. Texas Blues
9. Piedmont Blues
10. Street Preachers e Gospel Songs
11. Hillbilly & Country
12. Il superamento dell’hillbilly
13. Urban Folk
Una conclusione
Discografia
Bibliografia
Indice dei nomi
A tutti i neri
Di qualunque colore siano
Dovunque si trovino
1. The New World
…Innanzi tutto qualche indicazione di carattere generale e introduttivo. Prima che voce e suono fossero catturati e registrati su supporto la musica veniva commercializzata in forma di spartiti che i musicisti esecutori leggevano e riproducevano. Le prime trasformazioni e riduzioni dei suoni a ‘materia’ fissabile su supporto e poi destinabile al mercato avvennero a partire dalla fine degli anni ’80 dell’800 con i cilindri, piccoli barattoli metallici con una superficie di cera sulla quale si potevano incidere voci e musiche. La riproduzione avveniva in maniera esattamente inversa, e cioè collocando i cilindri registrati all’interno di uno strumento appositamente costruito (il fonografo, inventato da Thomas A. Edison) dove venivano fatti ruotare meccanicamente a circa 160 giri al minuto in modo da permettere alla puntina che li leggeva di trasmettere i suoni a una tromba acustica che li amplificava: “canned music”, “musica in scatola”, la definì con sufficienza e un velo di disprezzo il famoso bandleader e compositore John Philip Sousa. I cilindri potevano immagazzinare un paio di minuti di suono e lavorare una decina di volte prima di perdere le caratteristiche acustiche ma avevano il vantaggio di poter essere nuovamente registrati.
Fino all’inizio degli anni ’10 del ‘900 spartiti e cilindri furono le maniere più diffuse per commercializzare la musica, poi vennero affiancati dai dischi di gommalacca, le cui prime produzioni risalivano agli anni ’90 dell’800 ma che vennero introdotti in massa nel mercato solo nel 1908 dalla Columbia Phonograph Company. Si trattava di piatti pesanti e fragili che funzionavano in maniera simile ai cilindri ma non avevano possibilità di esser riregistrati perché la gommalacca era essiccata e rigida: venivano posti su un grammofono (l’evoluzione del fonografo) e, fatti ruotare a velocità variabili da 74 a 82 giri al minuto, inviavano il suono alla tromba acustica per mezzo di una puntina metallica che veniva appoggiata sopra di essi lavorando per inerzia. I primi dischi realizzati negli anni ’90 avevano un diametro di 7 pollici ma gli standard più diffusi divennero, col nuovo secolo, i 10 e i 12 pollici, i primi utilizzati principalmente per la musica popular e i secondi per la classica e l’operistica. La standardizzazione delle rotazioni a 78 giri al minuto, da cui il nome con cui oggi sono conosciuti (all’epoca per tutti erano semplicemente discs o records), arrivò nel 1925 con l’introduzione della sincronizzazione elettrica.
I primi anni del ‘900 videro quindi le compagnie fonografiche e discografiche di tutto il mondo (negli USA la partita si giocò tra Columbia ed Edison Records) in fermento per affermare prodotti di ogni tipo cercando affannosamente di migliorarne le caratteristiche e la capacità di contenere sempre più suono. Prototipi - non sempre posti in commercio - di cilindri e dischi in gomma, plastica, celluloide, resine diverse e cera sempre più irrobustita si susseguirono fino a che, a partire dagli anni ’10, non ebbero il sopravvento i dischi di gommalacca, che avevano una qualità di registrazione e di riproduzione meno buona dei cilindri e che inizialmente costavano il doppio (un dollaro contro cinquanta centesimi; per fare un confronto, lo stipendio annuo di un operaio si aggirava sui quattrocento dollari) ma presentavano diversi grossi vantaggi: erano più pratici da trasportare e più facili da riporre nei negozi perché occupavano solo spazio utile (a differenza dei cilindri), erano incisi sui due lati e quindi contenevano il doppio di musica e il loro prezzo divenne rapidamente concorrenziale su quello di tutti gli altri supporti. Furono queste caratteristiche, opportunamente aggiustate da una serie di accordi tra le compagnie discografiche (la politica dei prezzi, la spartizione dei mercati), a facilitare la diffusione dei dischi, che crebbe fino a sostituire definitivamente spartiti e cilindri segnando di fatto la nascita dell’epoca della musica registrata e del consumo di massa.
Le prime incisioni su vinile, destinate nel tempo a sostituire quelle di gommalacca, vennero prodotte dalla RCA Victor nel 1930; la resistenza e l’elasticità del nuovo materiale consentivano di produrre dischi dai solchi più sottili e ravvicinati e con rotazioni rallentate fino a 33 e 1/3 giri al minuto, permettendo quindi la fissazione di una quantità molto maggiore di musica e con una qualità acustica nettamente migliore perché il rumore di superficie del vinile era molto meno vistoso di quello della gommalacca. Nell’immediato però il vinile si rivelò un fallimento: la grande depressione economica che afflisse gli USA nella prima metà degli anni ’30 in seguito al crollo di Wall Street rese estremamente difficoltosa la penetrazione del nuovo supporto e la vendita di grammofoni adatti al suo uso. Alla fine degli anni ’30 iniziarono a far capolino i primi Extended Play con due o tre canzoni per lato (per esempio le “Dustbowl Ballads” di Woody Guthrie) ma fino alla fine della seconda guerra mondiale la produzione dei vinili restò limitata ai dischi promozionali per le radio e i locali da ballo. Fu solo nel 1948 che la Columbia lanciò definitivamente sul mercato il Long Play in vinile, registrato a 33 e 1/3 giri e capace di contenere ventitré minuti di musica per ciascun lato. L’anno seguente la RCA Victor produsse il primo 7” a 45 giri, che ebbe un immediato successo e che nel giro di pochissimi anni permise al vinile di sostituire definitivamente la gommalacca (che restò comunque nel mercato fino alla metà degli anni ‘50) aprendo la strada all’ennesima rivoluzione tecnica e artistica.
Dagli anni ‘10 al termine dei ’40 quindi il formato di stampa dominante in tutte le musiche popular fu quello del 10” di gommalacca che girava a 78 giri (circa) e conteneva una canzone per lato, ovviamente monofonica (la stereofonia arrivò nel 1958). Di conseguenza tutti i musicisti di cui parleremo in questo libro erano autori di semplici singoli; i LP e CD a loro attribuiti sono raccolte compilate a partire dagli anni ’50: fino ad allora difatti non esisteva neppure il concetto di ‘album’.
Il primo aspetto culturale da sottolineare in questa serie di rivoluzioni copernicane subite da quella che chiamiamo ‘musica pop’ nel corso del ‘900 è che essa nacque sulla base di evenienze tecniche ancor prima che da strategie commerciali o da esigenze artistiche. I musicisti affrontarono la novità rappresentata dai mezzi della musica registrata e dalle loro successive evoluzioni in maniera naturale, seguendone le forzature e adeguandosi alle distorsioni a cui essi costringevano. Come quando, nel 1928, arrivò il microfono a condensazione, che permise anche a chi aveva una voce non esattamente straordinaria (inevitabilmente richiesta, com’è ovvio, nelle registrazioni precedenti e ancor più nell’epoca pre-registrazione) di farsi sentire forte e chiaro. Questo permise anche a cantanti non particolarmente potenti ma magari più sottilmente espressivi di farsi largo e di elaborare nuove maniere non solo di intendere l’interpretazione di una canzone ma anche e soprattutto di reinterpretarla con arrangiamenti completamente nuovi e non più legati alla staticità d’accompagnamento del ‘bel canto’. Un discorso che sarebbe ripetibile con decine di altri esempi (uno per tutti quello della stereofonia): ciò che abbiamo avvertito come sviluppo artistico e/o distinzione e caratterizzazione estetica è quasi sempre dipeso da innovazioni tecnologiche e non da esigenze culturali.
La più significativa di tutte le svolte tecnologiche di cui la musica è stata protagonista e vittima fu però, come è ovvio, il concetto stesso di registrazione. In un 10” a 78 giri difatti non potevano esser stipati più di tre minuti di musica per lato (solo i 12” utilizzati per la classica arrivavano a cinque minuti) ed è facile comprendere come l’adattamento delle composizioni a quella lunghezza standard sia stata la più rilevante tra le innumerevoli manipolazioni indotte dal mercato sulla forma, e quindi sulla sostanza, musicale. È da questo semplice fatto tecnico che nacque la cognizione - avvertita ancora oggi - che la canzone popular debba avere, quasi inevitabilmente, una durata standard di tre minuti. Prima che venissero registrate e riprodotte tecnicamente, le canzoni avevano difatti lunghezze molto variabili: quelle utilizzate nei locali da ballo erano ben più lunghe di tre minuti e così quelle delle tradizioni rurali, che spesso ereditavano l’epicità (e la logorrea) delle antiche narrazioni folkloriche. Per fare un solo esempio, negli anni ’60 il bluesman Son House ricordava che le canzoni che ascoltava da bambino superavano tranquillamente i dieci minuti arrivando di frequente a toccare i venti (soprattutto nelle esecuzioni dal vivo). Questo significa che quando si trovarono a fare i conti con la possibilità di registrare la propria musica, i musicisti operarono un nettissimo scarto col passato e con la realtà adattando, tagliando o diluendo i ‘fronzoli’ e iniziando a badare all’essenza più immediatamente comunicativa come melodia, ritornello, accordi e scale facilmente memorizzabili.
La nascita del Long Play di vinile, che rese possibile la registrazione di tracce di lunghezze del tutto anomale e inedite rispetto alla prima metà del secolo (nonché l’ascolto di più canzoni in sequenza), spinse ulteriormente in avanti il discorso facendolo per certi versi tornare indietro come un gambero. Ciò che questo provocò esula dal nostro interesse ma è facile immaginare che, per esempio, se è vero che tutto quello che accadde al rock negli anni ‘60 (l’‘allargamento della coscienza’ musicale e non, la psichedelia, le suite, il progressive ecc. ecc.) doveva parecchio a contingenze socio-culturali come le proteste studentesche o la diffusione delle droghe, è ancor più vero che senza l’innovazione tecnologica portata dal LP tutte quelle contingenze sarebbero state nulla, almeno dal punto di vista musicale. È lecito chiedersi, quindi, quanta musica ‘prewar-psichedelica’ o ‘prewar-progressiva’ - indotta dagli stessi e persino maggiori usi e abusi che si registravano negli anni ’20 e ancor prima - ci siamo persi perché non è stata mai registrata…
È ovvio che l’assunto del non detto (perché ‘non rilevato’) sarebbe valido, oltre che per tutte le forme artistiche, anche per le epoche pre-registrazione: di ogni periodo storico sappiamo solo ciò che ci è stato tramandato, tutto il resto è ipotesi e supposizione. Ma a differenza di tutte le altre forme artistiche nate in epoche classiche la musica, con l’epoca della registrazione e del consumo di massa, divenne qualcosa di completamente diverso da prima. Divenne un’altra forma d’arte: un ‘media artistico’ in cui la mistificazione dei contenuti e la manipolazione della forma (ivi compreso l’utilizzo dello studio di registrazione come strumento) erano parte essenziale e creativa della sua natura più intima e non più stravolgimenti della stessa, come sarebbero stati vissuti nelle epoche precedenti, quando le sovrastrutture definivano (anche) le strutture.
La chiave di lettura delle musiche prewar (folk e non solo - diciamo pure di tutto il pop) passa esattamente da qui perché è dalla mancata comprensione dell’aver a che fare con un nuovo ‘media artistico’ - che come tale necessita di nuovi mezzi di interpretazione, lettura e indagine - che si sono generate le infinite distorsioni di cui il pop è stato oggetto nel corso del ‘900. In due parole, le puntigliose distinzioni tra popular music seria e autentica e popular music commerciale e relativi cascami critici che tanto inchiostro hanno fatto versare e tante discussioni hanno generato (e - ahinoi - continuano a generare) laddove ad essa vengono applicati criteri di lettura che non le appartengono (un po’ come discutere di pittura nell’analizzare una fotografia o pensare al cinema come se fosse teatro). Peraltro, fu proprio nel periodo della sua incubazione e del suo sviluppo che il mercato musicale dispiegò meglio la sua vitalistica, inarrestabile, formidabile capacità ‘dissimulatoria’: ecco perché i primi decenni del secolo scorso sono e resteranno i più significativi ed esemplari di tutta l’epoca della musica registrata.
Un rapido cenno riguardo la nascita del copyright sulle canzoni e la popolarità raggiunta dai musicisti in termini di vendite di dischi. Il copyright, croce e delizia di tante futili discussioni dei nostri giorni, nacque ufficialmente nel 1914 con l’ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers, la cugina della nostra SIAE. Furono cinque compositori, un librettista e tre rappresentati degli editori (i publishers) a creare l’associazione al fine di tutelare e regolamentare la diffusione pubblica della musica. Il mercato era infatti maturo perché anche chi scriveva le canzoni partecipasse al banchetto delle sue stesse creazioni, visto che fino ad allora non ne aveva ricavato quasi nulla e che gli unici a guadagnarci sopra erano le etichette che le pubblicavano e i locali (ristoranti, teatri, vaudeville) che le utilizzavano per attirare clienti e pubblico; si trattò insomma di un’istituzione molto simile a un sindacato che difendeva gli interessi del lavoro intellettuale come fosse un qualunque altro tipo di lavoro. Negli anni ’40, come vedremo tra breve, nacque anche una seconda associazione per la tutela degli interessi degli autori e degli editori, la BMI.
Per quanto riguarda la diffusione, nel 1909 le copie vendute di spartiti, cilindri e dischi furono complessivamente quasi 30 milioni e negli anni seguenti il trend aumentò continuamente fino a toccare i 100 milioni del 1919 e i 200 milioni del 1929; le canzoni più popolari arrivavano a vendere, a metà anni ’20, anche un milione e mezzo di copie. Nessuno di quanti saranno trattati in questo libro fu comunque una star nazionale, tutti restarono sempre limitati ai circuiti regionali; le uniche eccezioni furono Bessie Smith (12 presenze in classifica e un numero 1) e Jimmie Rodgers (8 presenze in classifica ma mai in vetta). Il colosso delle vendite della prima metà del secolo fu Bing Crosby con 294 presenze in classifica e 36 numeri 1; dietro di lui una marea di nomi tra i quali spiccano Paul Whiteman, Guy Lombardo e Billy Murray, ciascuno con oltre centocinquanta presenze e decine di numeri 1 (si noti però che di essi oggi non restano che pochissime tracce registrate, e questo deve pur significare qualcosa). Anche musicisti come Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, che sono giustamente considerati punti fermi dell’evoluzione del jazz e del pop, non furono mai celebrità nazionali se non settorialmente (i loro numeri 1 in classifica furono rispettivamente 3, 1, 1, 3 e 1), avevano ben pochi passaggi nelle radio nazionali, facevano pochi concerti nei luoghi che contavano e raramente apparivano nelle colonne sonore dei film. Questo per chiarire che tutto ciò di cui parleremo è definibile, con i parametri odierni, come perfettamente underground: le storie che tracceremo sono quelle degli antenati della musica alternative. Le distanze che separavano il mercato di massa - vale a dire quello popular sul serio - da quello underground erano incolmabili, un po’ come accade ancora oggi: lo spazio di quanti consideriamo giganti artistici, all’interno della globalità del business discografico, è sempre stato molto marginale.
I ‘generi’ musicali di cui ci occuperemo saranno riconducibili sostanzialmente al country blues e all’hillbilly-country, o meglio alle musiche identificate con questi nomi perché tipicizzate come proprie delle culture popolari nere e bianche; vedremo però che si trattava di distinzioni largamente opinabili poiché in ognuna di esse si nascondevano i semi dell’altra fino al punto di renderne indistinguibile l’origine etnica. La musica era acustica e gli strumenti utilizzati erano la chitarra, il banjo, il violino, i jug (recipienti di varia forma e natura da utilizzare soffiandoci dentro), l’armonica e la voce; l’elettrificazione arrivò alla metà degli anni ’30 ma impiegò oltre un decennio prima di affermarsi definitivamente. Le band non avevano sezioni ritmiche come le intendiamo oggi: l’utilizzo del basso e della batteria, mutuati dal jazz (e utilizzati, anche se molto parzialmente, solo nel classic blues, che fu un fenomeno limitrofo al country blues), divenne rilevante nel blues urbano e progressivamente elettrificato che si sviluppò a partire dagli anni ’30. A tenere il ritmo erano la chitarra o gli altri strumenti, spesso utilizzati in forma impropriamente percussiva.
Dimenticate quindi il blues e il country per come li avete conosciuti (e amati, e disprezzati) nella seconda metà del ‘900 e preparatevi ad ascoltarli in un formato quasi indistinguibile: fu difatti il sistema mercantile a indirizzare su esatti binari e coordinate suoni che vivevano proprio nella mancanza di binari e coordinate. Sin dalle loro prime stampe difatti tutte le musiche popolari iniziarono a esser falsate rispetto alla maniera in cui le si potevano ascoltare nelle epoche pre-registrazione, e non solo dal punto di vista strettamente tecnico (come già accenato). Fu l’introduzione del marketing dei generi e dei settori che, mutandone profondamente la natura, le destinò al consumo per fasce razziali ed economiche: fu così che nacquero i race records di blues (e jazz) e la hillbilly music, rispettivamente i dischi incisi da neri e destinati a un pubblico di neri e la musica dei contadini bianchi degli Appalachi, similmente rivolta a un consumo parallelo.
L’atteggiamento dell’industria discografica nel distinguere, catalogare e differenziare le canzoni per fasce etniche non era però dovuto a razzismo o a improbabili velleità puriste; questo è solo l’aspetto più insistentemente sottolineato dalle frange più pateticamente politicizzate della critica, che si crogiola(va)no nella perpetua lamentazione dei condizionamenti razziali e razzisti del mercato e della cultura americani. È indubbio, ovviamente, che i sentimenti diffusi della società bianca fossero tali ma nel concreto del discorso mercantile essi restarono sempre marginali o comunque significativi solo di riflesso. La realtà dell’industria era molto più semplice: differenziare il mercato il più possibile. La cultura bianca americana, si sa, è innanzi tutto pragmatica, e particolarmente se si tratta di business. Sin dai suoi esordi l’industria discografica (in realtà qualunque tipo di industria) tese alla moltiplicazione dei settori perché la differenziazione stabilisce, sostiene e rafforza l’autoriconoscibilità dei consumatori e quindi il loro attaccamento al prodotto, soprattutto in un ambito dalla forte partecipazione emotiva come era (è) quello media-artistico della musica pop. Più il mercato si allarga (o, se si preferisce, al fine di allargare il mercato), più diventa necessario creare nicchie particolari, originali, uniche all’interno delle quali ogni singolo ascoltatore riesce a riconoscersi per trasformarsi in consumatore consenziente e attivo. La storia della musica del ‘900 - non solo popular - non è altro che un susseguirsi di mode e trend esattamente per questo: la creazione di hillbilly records e race records non ne fu che la prova generale e, in questo, anche la più perfetta e a tutt’oggi insuperata delle prove. L’unica a essere completamente eterodiretta, è importante sottolineare, laddove tutte le seguenti, dal r’n’r al beat, dalla psichedelia al prog, dal punk al post rock all’hip hop e quant’altro, nacquero sempre dall’interazione col pubblico di massa e dai cortocircuiti socioculturali che esso esprimeva ed esprime. A dispetto di come potrebbe apparire, inoltre, la divisione commerciale tra hillbilly e race records fu una manna dal cielo per tutti, in particolar modo per le comunità nere. Perché fece la fortuna di moltissimi diseredati senza arte né parte, fu la formula magica che permise la creazione di un radicato e sempre più florido mercato afroamericano altrimenti ben difficile anche da ipotizzare. Il ghetto, in tal senso, pagò (e paga ancora) benissimo…
© Tuttle Edizioni 2008
Prezzo: 7 €
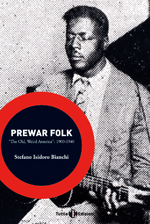
Sintetica:Dalle prime incisioni su disco negli anni ’10 a Woody Guthrie e Pete Seeger, la storia dell’America dimenticata dei primi decenni del Novecento, quella del folk in bianco e nero che pose le basi della musica popular di tutto il secolo. Una vicenda dimenticata e rimossa che vede protagonisti poveri diseredati ed eccentriche dive, ingenui contadini e scaltri professionisti, vagabondi disperati e avventurieri senza scrupoli, peccatori e santi, clown da quattro soldi ed entertainers raffinati: gli autentici geni di una musica che inventò il rock decenni prima che lui nascesse.
Keywords:Prewar Folk: the Old, Weird America 1900-1940 Dalle prime incisioni su disco negli anni ’10 a Woody Guthrie e Pete Seeger, la storia dell’America dimenticata dei primi decenni del Novecento, quella del folk in bianco e nero che pose le basi della musica popular di tutto il secolo. Una vicenda dimenticata e rimossa che vede protagonisti poveri diseredati ed eccentriche dive, ingenui contadini e scaltri professionisti, vagabondi disperati e avventurieri senza scrupoli, peccatori e santi, clown da quattro soldi ed entertainers raffinati: gli autentici geni di una musica che inventò il rock decenni prima che lui nascesse.